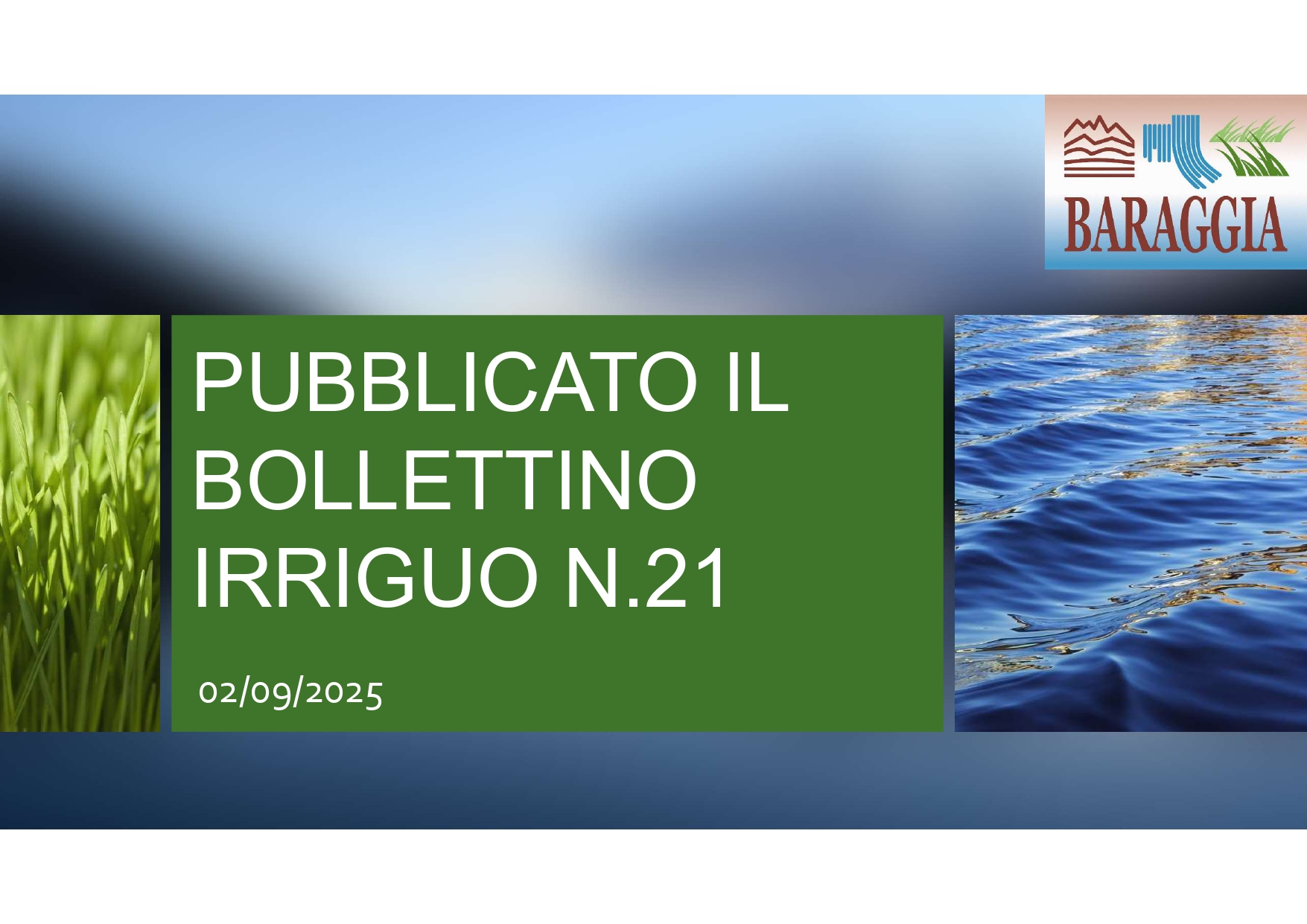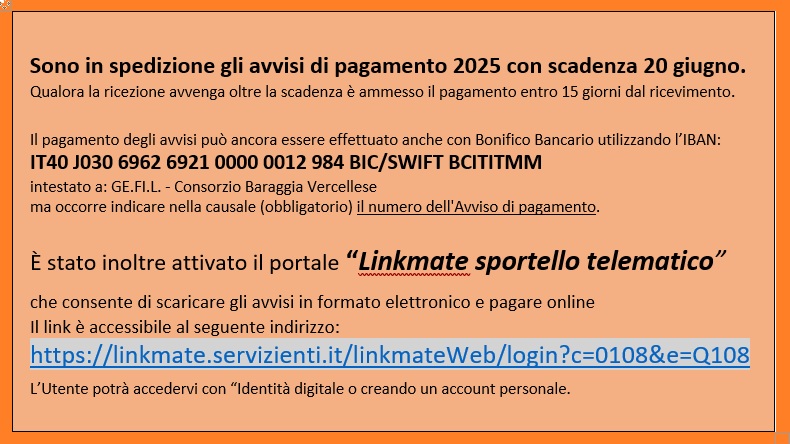Qual è il confine che separa l’emergenza siccità dal rischio alluvioni? Il tema, più che mai attuale, rappresenta per la Baraggia una lotta secolare.

Invaso della Ravasanella, Roasio (VC)
La ricerca costante dell’acqua per irrigare i campi e la difesa dalle piene per salvaguardare le coltivazioni e i suoi abitanti è un equilibrio che non nasce in modo naturale nelle selvagge e asfittiche terre di Baraggia. La bonifica del territorio, a partire dalla metà del secolo scorso, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa porzione di provincia tra Biella e Vercelli. Infrastrutture di rilievo sono state costruite dopo la costituzione del Consorzio di Bonifica Biellese e Vercellese nel 1950. I tre invasi, Ostola a Masserano, Ravasanella a Roasio e Ingagna a Mongrando, sono l’esempio più significativo del complesso sistema di opere idrauliche che permette il funzionamento del ciclo dell’acqua.
Gli invasi hanno prioritariamente una funzione irrigua, raccogliendo l’acqua piovana prevalentemente in autunno ed in primavera, per distribuirla gradualmente a valle, verso i campi, per la sommersione delle risaie in estate. Altra funzione fondamentale svolta dagli invasi è nel campo della sicurezza idrogeologica provvedendo attivamente alla laminazione delle piene durante i periodi di pioggia intensa, proprio come avvenuto recentemente alla fine di questo novembre.

Invaso della Ravasanella, Roasio (VC)
Abbiamo intervistato a questo proposito l’Ing. Domenico Castelli, progettista della società di ingegneria Steci srl, che ha seguito la realizzazione degli invasi del Consorzio (Ingagna, Ostola e Ravasanella) nonché la progettazione di altri in provincia di Cuneo, tutti invasi caratterizzati principalmente da 4 funzioni gestionali: di irrigazione, potabile, laminativa ed idroelettrica.
In che modo le dighe sono utili a ridurre il rischio alluvioni?
“La laminazione delle piene consiste nella riduzione della portata massima dei corsi d’acqua che si sviluppa durante le piogge intense” spiega Castelli. “L’onda di piena si genera per effetto della trasformazione della pioggia che cade sul comprensorio montano e che tramite il fiume transita verso valle. Questo è un meccanismo variabile nel tempo, che aumenta man mano che i contributi delle singole valli si sommano, arrivando ad un valore massimo finché la pioggia non cala e gli afflussi si riducono insieme alla portata dell’alveo”. Ed è qui che arriviamo al ruolo degli invasi: “Grazie alla costruzione di laghi artificiali è possibile trattenere la portata al colmo, restituendola gradualmente verso valle quando le piogge sono meno intense o assenti. La laminazione contribuisce così anche alla protezione e alla sicurezza dei territori, evitando episodi alluvionali nei centri urbani durante le precipitazioni più intense”.
Quando la diga arriva a sfiorare c’è qualche rischio per i centri urbani limitrofi?
“Per restituire l’acqua la diga deve arrivare a sfiorare. Intanto non è così facile alzare il livello dell’acqua anche solo di pochi centimetri su una superficie enorme come un lago. Per farlo ci vogliono ore e, durante quel lasso di tempo, l’intensità della pioggia si sarà inevitabilmente ridotta”. In questo senso anche nel caso in cui la diga arrivi a sfiorare l’effetto è comunque benefico: “Per effetto del tempo necessario ad innalzare il livello del lago, quando la diga sfiora determinerà un’onda di piena sempre comunque inferiore a quella che naturalmente sarebbe passata in assenza del lago, contribuendo così a ridurre notevolmente il rischio di alluvioni”. Insomma, per sfatare alcuni miti negativi legati alle dighe, l’effetto di laminazione è sempre comunque assicurato durante le piene.

Invaso dell'Ostola, Masserano (BI)
La diga dell’Ingagna è l’ultima opera realizzata dal Consorzio e quella forse più importante. Qual è il suo valore aggiunto rispetto a Ostola e Ravasanella?
“Terminato nel 1991, quello sull’Ingagna a Mongrando è l’invaso maggiore per estensione, con una capacità di oltre 7 milioni di mc, il primo in Piemonte e uno dei primi in Italia ad essere sottoposto ad un piano di laminazione dinamico. Individuato il periodo di maggiore probabilità delle piene (in genere in autunno, dal 15 settembre al 15 novembre), al monitoraggio delle condizioni meteo sfavorevoli, si fanno degli svasi preventivi per accrescere il potere laminativo della diga. Questo piano di laminazione dinamico delle piene è entrato in vigore nel 2014 e permette di programmare gli svasi, riducendo il rischio allagamenti, in particolare nel centro abitato di Mongrando. Il torrente Ingagna è idrogeologicamente idoneo a consentire il deflusso di portate fino ad una portata di 70-73 mc al secondo; oltre a quel valore comincerebbero ad esserci i primi problemi esondativi, ma con il piano di laminazione dinamica si possono controllare in maniera efficiente le portate, sfasandole nel tempo per restare sempre al di sotto di tali valori. Questa funzione fu fondamentale durante le alluvioni del 1994, 2000 e 2002”.
Cosa succede all’acqua che viene svasata durante i periodi di piena? Viene in qualche modo recuperata?
“L’acqua fuoriuscita dall’invaso torna nella sua sede naturale, il torrente Ingagna, e procede il suo transito verso valle. L’acqua in eccesso, in questi casi, non può essere trattenuta a uso irriguo ma, limitatamente, può essere sfruttata idroelettricamente attraverso le due 2 centraline ubicate a Mongrando ed a Magnonevolo (Cerrione). Un ulteriore uso, molto importante, delle acque dell’invaso dell’Ingagna è quello potabile: l’acqua è trattata al piede della diga, dove c’è un impianto di potabilizzazione, e da qui è distribuita verso la pianura vercellese. Già oggi si serve un comprensorio che arriva fino a Collobiano, in pratica alle porte della città di Vercelli.
L’uso principale dell’invaso resta comunque quello irriguo: l’acqua è distribuita mediante un grande impianto a pioggia, a caduta naturale e senza alcun costo di sollevamento, per bagnare campi di mais e prato in estate”.

Invaso dell'Ingagna, Mongrando (BI)
Il risparmio non va inteso solo in senso economico, ma soprattutto ambientale: in questo momento storico la tutela delle risorse naturali ha un valore ancora più significativo. Di fronte ai continui segnali che testimoniano un cambiamento climatico custodire l’acqua è una questione di sicurezza per chi ne beneficia oggi e una fonte di salvezza per le generazioni future.
“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli” (1852, Capo Seattle)